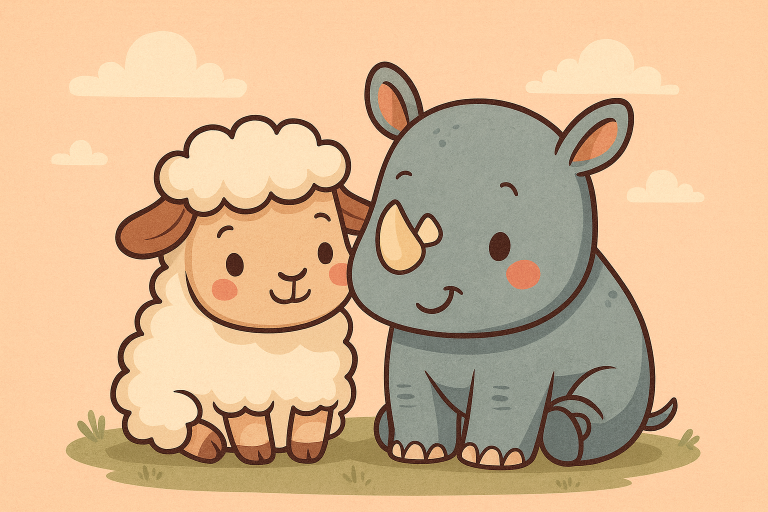L’aura degli Italian Innovators
Come si racconta all’estero l’italianità, tra cultura e imprenditoria, utilizzando un linguaggio moderno come dei video su YouTube?
Come si racconta all’estero l’italianità, tra cultura e imprenditoria, utilizzando un linguaggio moderno come dei video su YouTube? Luca Cottini, scrittore, storyteller e ricercatore alla Villanova University di Philadelphia, varesino di nascita, parla della forza dell’innovazione italiana, tra impresa e valore, portando oltre oceano esempi di aziende che “si concepiscono operatori di cultura”
‘‘Se hai del buon vino hai due possibilità. Ti chiudi in cantina e ti ubriachi o lo condividi”. La metafora di Luca Cottini descrive alla perfezione un lavoro di ricerca e narrazione che mette al centro il valore, anche in termini economici, della capacità di innovazione del nostro Paese. Varesino di nascita, oggi professore associato di studi italiani alla Villanova University di Philadelphia, Cottini è personalità poliedrica che per sua stessa definizione “vive in due mondi”. In America, dove ha messo radici ormai da quasi 20 anni, racconta l’italianità, tra cultura e imprenditoria; in Italia, a cui restituisce un lavoro prestigioso, ma soprattutto un punto di vista da un osservatorio privilegiato. Uno dei suoi progetti, “Italian Innovators”, ritratti a tutto tondo di persone che hanno fatto la storia dei nostri principali marchi, raccontati su YouTube, racchiude al massimo quella che è la sua visione della capacità d’impresa nostrana.
Come è nato questo percorso?
La mia è una formazione classica, che affonda le radici nello studio del greco e del latino al Liceo Classico E. Cairoli di Varese. Sono “figlio d’arte”: mio papà, “il Prof. GP” Cottini era amatissimo: una specie di istituzione in città. Mi sono avvicinato all’insegnamento con questo bagaglio anche pesante, ma con un’idea personale molto chiara: volevo continuare ad insegnare, senza smettere di studiare. Una vocazione ben definita, che mi ha portato negli Usa dove ricerca e insegnamento sono un mestiere unico. Curiosamente mi sono ritrovato a fare un master e un dottorato di studi italiani prima all’Università di Notre Dame in Indiana e poi ad Harvard, dove ho trascorso i miei anni di “studio matto e disperatissimo”. Da lì poi, passando dal Canada, il mio percorso di insegnamento e ricerca mi ha portato qui, in Pennsylvania.
In pratica, si occupa di italianità. È curioso che lo faccia dagli Stati Uniti!
Non è strano. Essere all’estero permette di osservare l’Italia in modo diverso. Prima di tutto, guardarla da qui, significa guardarla intera nella sua complessità da Nord a Sud. Nello stesso tempo, osservare da qui permette di non avere un approccio a compartimenti stagni ma di mettere insieme più ambiti, come la letteratura, il cinema, il design e l’industria, acquisendo una visione globale. Gli americani, poi, sono grandi appassionati della nostra cultura, da Dante e Petrarca a Verdi e Fellini. Da qui l’osservazione del modello culturale e produttivo italiano emerge più chiaramente.
Cioè?
Noi siamo abituati a delimitare il nostro valore aggiunto con l’etichetta del made in Italy, che non è sbagliata, ma è riduttiva. Come racconto nel mio libro “The Art of Objects: The Birth of Italian Industrial Culture”, il nostro modello ha qualcosa di più: nasce dal bisogno storico tra fine ‘800 e primi del ‘900 di posizionarsi in mercati già occupati da altri. Come si affronta questo bisogno, come ci si rende unici? Il nostro modello d’innovazione coincide così con la scelta di aggiungere un qualcosa di intangibile, un elemento culturale e di design, all’oggetto di consumo. E così l’impresa si fa arte, superando la dimensione seriale o effimera del prodotto: Bianchi ha scelto Boccioni, Campari ha scelto Depero, Borletti ha scelto D’Annunzio per creare il brand La Rinascente. Marchi come Olivetti, Gucci e Ducati hanno creato dei musei per raccogliere i loro prodotti classici. A testimonianza del fatto che le imprese si concepiscono operatori di cultura.
E come nasce l’idea di raccontarlo sui social?
L’idea è proprio quella della condivisione di storie: dai grandi nomi del passato (senza dimenticare un omaggio alla sua città, Varese, raccontando Ferragamo, ndr) ai contemporanei, come Mauro Porcini o Clio Zammatteo, in arte Clio Makeup. Se hai il buon vino, lo devi condividere: questa era l’idea semplice alla base del progetto. Poi però è andato oltre le aspettative, viaggiando veloce sugli incredibili binari del digital marketing che mi hanno avvicinato a fruitori da tutto il mondo. Fa un certo effetto sapere che mi seguono anche a Mumbai! Su una struttura leggera come YouTube, investigare un diverso modello di approccio al business si è rivelato vincente. Racconto valore. E il valore, come nella doppia valenza etimologica della parola “profitto” è un capitale (o letteralmente un “beneficio”) sia morale sia economico. Un concetto così ovvio di cui però ci siamo dimenticati.
Il racconto è idealmente destinato a tutto il mondo. Gli americani, come lo accolgono?
Il pubblico americano è attento: se racconti bene qualcosa, ti segue. È un modo diverso di avvicinarsi al sapere il loro. Anche il rapporto con i libri è diverso: noi studiamo tutta la letteratura, ma spesso parliamo di opere che non abbiamo davvero letto, mentre qui lo fanno integralmente. Allo stesso modo gli americani hanno molta attenzione nei confronti del prodotto italiano. Sono disposti a spendere di più ma solo se spieghi loro il perché. Il nostro saper fare ha per gli americani un’aura, un flair, qualcosa di invisibile, eppure che brucia. L’Italia non crea progetti ma storie. Io le racconto, cercando di rendere intellegibile il mondo da cui nascono.
Tra queste c’è anche quella di Michele Ferrero, per tutto il mondo l’inventore della Nutella, al quale ha dedicato un libro, “Il fabbricante di cioccolato”, edito nel 2023 da Piemme. È una biografia?